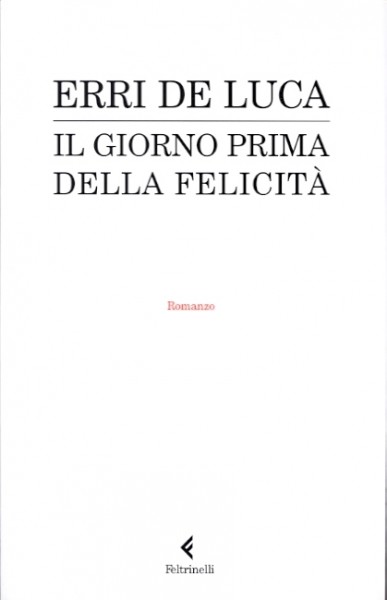Scoprii il nascondiglio perché c’era finito il pallone. Dietro la nicchia della statua, nel cortile del palazzo, c’era una botola coperta da due tavolette di legno. Mi accorsi che si muovevano quando ci misi i piedi sopra. Mi prese paura, recuperai la palla e sgusciai fuori tra le gambe della statua.
Solo un bambino smilzo e contorsionista come me poteva infilare la testa e il corpo tra le gambe poco divaricate del re guerriero, dopo aver aggirato la spada piantata giusto davanti ai piedi. La palla era finita lì dietro, dopo un rimbalzo di sponda tra la spada e la gamba.
La spinsi in fuori, gli altri ripresero il gioco, mentre mi attorcigliavo per uscire. Le trappole sono facili a entrare ma per uscire c’è da sudare. Avevo pure una fretta di paura. Ripresi il mio posto in porta. Mi facevano giocare con loro perché recuperavo la palla dovunque finiva. Una destinazione abituale era il balcone del primo piano, una casa abbandonata. La voce era che ci abitava un fantasma. I vecchi palazzi contenevano botole murate, passaggi segreti, delitti e amori. I vecchi palazzi erano nidi di fantasmi.
Andò così la prima volta che salii al balcone. Dal finestrino a pianoterra del cortile dove abitavo, il pomeriggio guardavo il gioco dei più grandi. Il pallone calciato male schizzò in alto e finì sul terrazzino di quel primo piano. Era perduto, un superflex paravinil un po’ sgonfio per l’uso. Mentre che bisticciavano sul guaio mi affacciai e chiesi se mi facevano giocare con loro. Sì, se ci compri un altro pallone. No, con quello, risposi. Incuriositi accettarono. Mi arrampicai lungo un tubo dell’acqua, discendente, che passava accanto al terrazzino e proseguiva in cima. Era piccolo e fissato al muro del cortile con dei morsetti arrugginiti. Cominciai a salire, il tubo era coperto da polvere, la presa era meno sicura di quello che mi ero immaginato. Mi ero impegnato, ormai. Guardai in su: dietro i vetri di una finestra del terzo piano c’era lei, la bambina che cercavo di sbirciare. Era al suo posto, la testa appoggiata sulle mani. Di solito guardava il cielo, in quel momento no, guardava giù.
Dovevo continuare e continuai. Per un bambino cinque metri sono un precipizio. Scalai il tubo puntando i piedi sui morsetti fino all’altezza del terrazzino. Sotto di me si erano azzittiti i commenti. Allungai la mano sinistra per arrivare alla ringhiera di ferro, mi mancava un palmo. In quel punto dovevo fidarmi dei piedi e stendere il braccio che teneva il tubo. Decisi di farlo di slancio e ci arrivai con la sinistra. Ora dovevo portarci la destra. Strinsi forte la presa sul ferro del terrazzo e buttai la destra ad afferrare. Persi l’appoggio dei piedi: le mani ressero per un momento il corpo nel vuoto, poi subito un ginocchio, poi due piedi e scavalcai. Com’è che non avevo avuto paura? Capii che la mia paura era timida, per uscire allo scoperto aveva bisogno di stare da sola. Lì invece c’erano gli occhi dei bambini sotto e quelli di lei sopra. La mia paura si vergognava di uscire. Si sarebbe vendicata dopo, la sera al buio nel letto, col fruscio dei fantasmi nel vuoto.
Buttai il pallone di sotto, ripresero a giocare senza badare a me. La discesa era più facile, potevo stendere la mano verso il tubo contando su due buoni appoggi per i piedi sul bordo del terrazzino. Prima di allungarmi verso il tubo guardai veloce al terzo piano. Mi ero offerto all’impresa per desiderio che si accorgesse di me, minuscolo scopettino da cortile. Era lì con gli occhi sbarrati, prima che potessi azzardare un sorriso era scomparsa. Stupido a guardare se lei stava guardando. Bisognava crederci senza controllare, come si fa con gli angeli custodi. Mi arrabbiai con me buttandomi lungo il tubo in discesa per togliermi da quel palcoscenico. Sotto mi aspettava il premio, l’ammissione al gioco. Mi misero in porta e fu così deciso il mio ruolo, sarei diventato portiere.
Da quel giorno mi chiamarono “‘a scigna”, la scimmia.
***
“Allora è vero, don Gaetano, quello che dicono di voi, che voi sentite i pensieri in testa alle persone?”
“È vero e non è vero, certe volte sì e certe no. Meglio così perché la gente fa brutti pensieri.”
***
“Una persona ci mette una vita a riempire gli scaffali e un figlio non vede l’ora di vuotarli e buttare via tutto. Che ci mettono sugli scaffali vuoti, i caciocavallo? Basta che me li levate di torno, mi dicono. E là ci sta la vita di una persona, i suoi sfizi, le spese, le rinunce, la soddisfazione di vedere crescere la propria cultura a centimetri come una pianta.”
***
Era estate e mi tornava spesso il gonfiore ai pantaloni. Don Gaetano mi insegnò qualche lavoro semplice di elettricità e di idraulica, per mandarmi a fare qualche riparazione al posto suo. Prendevo qualche mancia. Un pomeriggio alla solita chiamata della vedova disse che salivo io. Mi presentai con la cassetta dei ferri, mi fece entrare. Pure in casa portava un cappellino con la veletta nera. Le persiane erano chiuse, una penombra fresca. Mi fece strada in bagno a riparare lo scarico del lavandino. Mi abbassai per svitare il sifone, lei rimase vicina, le ginocchia nude mi stavano all’altezza degli occhi. Mentre forzavo il pezzo con la chiave inglese le sue ginocchia cominciarono a urtarmi con piccole spinte. Mi venne saliva in bocca da buttare giù. La sua mano entrò nei miei capelli a smuoverli, smisi il lavoro, restai fermo. Me li strinse e cominciò a tirarli verso l’alto. Lasciai la chiave inglese, le obbedii. Spense la luce e spinse il ventre contro il mio. Le sue braccia mi salirono al collo e lo strinsero spingendolo piano incontro alla sua faccia. Mi aprì la bocca con due dita e poi con le sue labbra. Alzai le mani per una risposta, me le prese e se le mise dietro la schiena. Poi mi cercò il sesso. Ero di schiena al lavandino, spinse contro di me e il sesso le entrò in corpo. Mi muoveva. Era più bello che dentro la nuvola. Mi alzò le mani sopra il petto e cominciò a soffiare, in crescita, fino a una spinta che mi portò via tutto il sangue che avevo. Era successa una trasfusione da me a lei. Doveva essere questo il facimm’ammore che si dicono gli uomini e le donne.
Ero sudato, le mutande ai piedi, la schiena indurita per aver sostenuto le sue spinte senza appoggiarmi al lavandino. Si staccò da me, accese la luce e si lavò tra le gambe. Mi disse di fare lo stesso. Poi raccolsi i ferri. “Se ho bisogno ti chiamo.” “Sì signora.” E questa fu la mia prima riparazione.